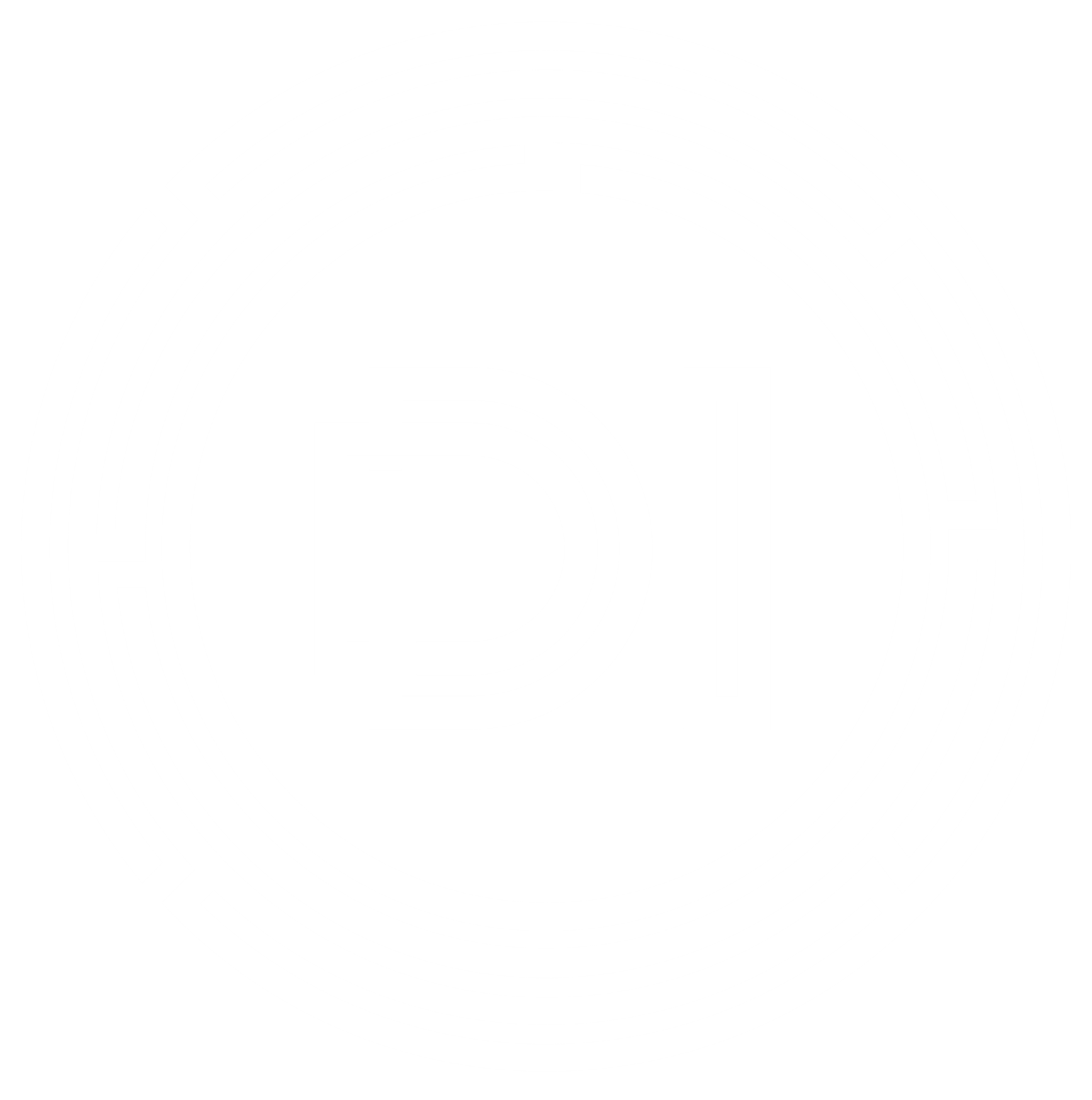5. Perché procrastiniamo? Bias del presente, scelte quotidiane e possibili soluzioni
- Information
- Finanza comportamentale 41 hits
- Prima pubblicazione: 28 Aprile 2025
«Vi sono pochissimi uomini – e sono le eccezioni – capaci di pensare e sentire al di là del momento presente».
Carl von Clausewitz
Molte decisioni che affrontiamo nella vita quotidiana richiedono di bilanciare costi e benefici nel tempo, ma il modo in cui valutiamo il futuro rispetto al presente non sempre segue una logica coerente.
Negli ultimi decenni, la ricerca economica e comportamentale ha mostrato come le persone tendano spesso a privilegiare il presente, faticando a rispettare i propri piani di lungo termine.
Sono stati pertanto sviluppati modelli alternativi alla teoria classica, capaci di spiegare perché, in molte situazioni, le nostre scelte non sono razionali.
Nel primo capitolo, approfondiremo queste dinamiche, per poi esaminare alcune delle loro applicazioni più rilevanti nella vita quotidiana e nelle decisioni economiche.
L’obiettivo è comprendere meglio le radici di certi comportamenti apparentemente “irrazionali” e riflettere su come strumenti e politiche possano aiutare le persone a colmare il divario tra intenzioni e azioni.
Indice
- Preferenze temporali e present bias
- La domanda di commitment device (dispositivi di impegno)
- Applicazioni empiriche del present bias
- Punti di forza e critiche
- Conclusioni
1. Preferenze temporali e present bias
Le decisioni che prendiamo ogni giorno comportano spesso la valutazione di costi o benefici che si manifesteranno in momenti futuri.
Dalla scelta di risparmiare per la pensione all'impegno in un'attività noiosa oggi per ottenere un vantaggio domani, il modo in cui attribuiamo valore ai risultati futuri rispetto a quelli immediati gioca un ruolo centrale.
Il modello economico tradizionale assume uno sconto esponenziale, ipotizzando una coerenza delle preferenze nel tempo: in altre parole, il nostro grado di impazienza tra due date future rimane costante, indipendentemente da quanto queste siano lontane.
Eppure, comportamenti diffusi come la procrastinazione o l’eccessivo ricorso al debito indicano che le nostre preferenze temporali sono più complesse e talvolta incoerenti.
Come abbiamo visto negli articoli precedenti, un modello che descrive in modo più realistico questo tipo di comportamento è quello dello sconto quasi-iperbolico, noto anche come modello beta-delta.
Questo approccio introduce l’idea di un forte “sconto” applicato ai risultati nel futuro immediato rispetto a quelli più lontani, un fenomeno conosciuto come present bias.
In termini formali, questo meccanismo è rappresentato da due parametri: il parametro β (beta), solitamente inferiore a 1, che riduce nel presente il valore percepito di tutte le ricompense future, e il parametro δ (delta), vicino a 1, che applica uno sconto esponenziale standard ai guadagni futuri.
Per fare un esempio, ricevere 100 euro oggi può sembrare molto più vantaggioso rispetto a riceverne 101 domani (uno sconto elevato per un solo giorno di attesa). Al contrario, la differenza tra ottenere 100 euro tra un anno e 101 euro tra un anno e un giorno appare quasi irrilevante.
Chi manifesta present bias (cioè quando β < 1) può mostrare una certa incoerenza nelle proprie decisioni nel tempo: un piano che sembra ragionevole se pensato per il futuro – come iniziare a studiare la prossima settimana – rischia di essere continuamente rimandato quando “la prossima settimana” diventa “oggi”, perché il costo immediato dello sforzo viene percepito come molto più pesante nel presente.
Questa tensione tra il “sé presente”, più impaziente, e i “sé futuri”, considerati più pazienti, è alla base di numerosi comportamenti osservabili nella pratica, analizzati attraverso diverse applicazioni empiriche.
2. La domanda di commitment device (dispositivi di impegno)
Una delle conseguenze più rilevanti del present bias, soprattutto per le persone consapevoli di questa propria tendenza (i cosiddetti agenti “sofisticati”), è il possibile ricorso ai dispositivi di impegno.
Si tratta di meccanismi volontari pensati per limitare le scelte future, con l’obiettivo di aiutare l’individuo a rispettare i propri piani di lungo termine, evitando che il present bias comprometta il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In altre parole, sono strategie per “legarsi le mani” e rendere più difficile cedere alle tentazioni nel futuro.
In un modello di sconto esponenziale, dispositivi di questo tipo non sarebbero necessari, poiché le preferenze rimarrebbero stabili nel tempo e non ci sarebbe motivo di voler limitare le proprie opzioni future.
Alcuni esempi di dispositivi di impegno, discussi sia nella letteratura che nella pratica, includono:
- Siti web come StickK: consentono di fissare obiettivi e di “scommettere” una somma di denaro, che viene persa se l’obiettivo non viene raggiunto entro una certa scadenza. In alcuni casi, il denaro può essere destinato a un’organizzazione con valori opposti ai propri (una sorta di "anti" ente di beneficenza), rendendo il fallimento ancora più spiacevole.
- Blocco di siti web o app: software o estensioni del browser che impediscono l’accesso a fonti di distrazione, come social media o siti di notizie, in determinati orari. L’efficacia di questi strumenti può però diminuire se il blocco è facilmente aggirabile.
- Annunci pubblici: dichiarare apertamente un obiettivo – per esempio, “smetterò di fumare” – può generare una forma di pressione sociale, rendendo più difficile tornare sui propri passi per timore del giudizio degli altri o della vergogna.
- Restrizioni fisiche: consiste nel rendere più scomode le azioni indesiderate (ad esempio, mettere la sveglia lontana dal letto per costringersi ad alzarsi) oppure nell’associare un’attività piacevole a un’attività impegnativa ma utile (come ascoltare un audiolibro solo mentre si è in palestra, come suggerito nello studio di Milkman et al.).
- Conti di risparmio vincolati: strumenti come i fondi pensione, che prevedono limitazioni ai prelievi anticipati, oppure prodotti come il SEED account nelle Filippine, che limitano l’accesso ai fondi fino al raggiungimento di un obiettivo prestabilito.
- Acquisto in piccole quantità: comprare snack o sigarette in confezioni più piccole, anche se meno convenienti a livello di prezzo per unità, per limitare il consumo futuro.
L’efficacia di un dispositivo di impegno dipende dalla sua capacità di rendere abbastanza costoso deviare dal piano prefissato rispetto alla forza della tentazione nel momento presente.
Perché uno strumento di questo tipo funzioni davvero, devono essere soddisfatte alcune condizioni:
- Presenza di un problema di autocontrollo (present bias): l’individuo deve essere soggetto a una preferenza eccessiva per le gratificazioni immediate rispetto a quelle future.
- Almeno una parziale consapevolezza del problema (agente “sofisticato”): la persona deve riconoscere la propria tendenza a rimandare o a non rispettare i piani stabiliti.
- Scelta di un dispositivo realmente vincolante: lo strumento deve essere tale da non poter essere facilmente aggirato o disattivato.
- Fiducia nell’efficacia del dispositivo: l’individuo deve credere che il meccanismo scelto sarà utile per raggiungere l’obiettivo desiderato.
- Assenza di facili sostituzioni con altri comportamenti dannosi: il dispositivo non deve semplicemente spostare il problema altrove, come ad esempio smettere di navigare al computer ma trascorrere comunque ore sullo smartphone.
3. Applicazioni empiriche del present bias

«It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with experiment, it's wrong».
Richard Feynman
Numerosi studi empirici hanno utilizzato il modello quasi-iperbolico per spiegare diversi comportamenti legati all’autocontrollo.
Tra questi, uno dei più evidenti è la procrastinazione, ossia la tendenza a rimandare attività che comportano costi immediati (come lo sforzo richiesto per studiare o lavorare) e benefici solo nel futuro (come ottenere buoni voti o completare un progetto).
Come le scadenze influenzano la procrastinazione
Uno degli studi più noti su questo tema è quello di Ariely e Wertenbroch, che hanno analizzato l’impatto delle scadenze sulla procrastinazione. Sono stati effettuati due esperimenti, nei quali gli autori hanno confrontato tre tipi di scadenze (imposte, auto-imposte e assenti) per valutare l’efficacia nel contrastare la procrastinazione.
I risultati mostrano che le scadenze esterne distribuite nel tempo migliorano le prestazioni proprio perché agiscono come dispositivi di impegno, mentre le scadenze auto-imposte, pur parzialmente efficaci, suggeriscono una diffusa difficoltà nel vincolarsi in modo ottimale.
Questi esiti risultano coerenti con le previsioni del modello quasi-iperbolico, secondo cui il present bias porta a rimandare attività con costi immediati e benefici futuri, e rende spesso necessario un impegno esterno per mantenere i piani.
Tra le critiche rivolte a questo tipo di studi vi sono le dimensioni ridotte dei campioni e, nel primo esperimento di Ariely e Wertenbroch, la mancata assegnazione casuale dei partecipanti ai gruppi, che potrebbe aver introdotto differenze non legate alle scadenze.
Anche quando l’assegnazione è casuale, come nel secondo esperimento, l’interpretazione dei risultati richiede cautela: la scelta stessa delle scadenze potrebbe essere influenzata da caratteristiche personali non osservabili.
Carte di credito e tentazione del breve termine
Un altro ambito in cui il present bias trova applicazione è il comportamento dei consumatori nell’uso delle carte di credito.
Negli Stati Uniti, le società emittenti offrono spesso tassi di interesse promozionali molto bassi (teaser rates) per un periodo iniziale – ad esempio, sei mesi al 4,9% – seguiti da tassi standard molto più elevati, come il 16%.
Un consumatore soggetto a present bias tende a concentrarsi sul basso costo immediato del prestito, sottovalutando però il peso che avranno gli interessi più alti nel futuro.
Questo tipo di comportamento è coerente con l’ipotesi della parziale ingenuità: l’individuo riconosce di aver bisogno di liquidità nel breve termine, ma si illude di riuscire a ripagare il debito prima che il tasso promozionale scada.
In realtà, sottostima il proprio futuro present bias o le possibili difficoltà finanziarie che potrebbero impedirgli di estinguere il debito in tempo.
Un contributo importante su questo tema è il lavoro di Ausubel, che documenta come le offerte con teaser rates più bassi attraggano una maggiore adesione da parte dei consumatori, anche quando le alternative presentano condizioni complessivamente più vantaggiose nel lungo periodo (ad esempio, un tasso iniziale leggermente più alto ma con tassi successivi più bassi).
Non è tuttavia semplice distinguere questo tipo di comportamento da altre possibili spiegazioni, come ad esempio disattenzione, ottimismo ingiustificato o errata percezione dei tassi futuri.
Raccogliere dati sulle convinzioni delle persone riguardo al proprio futuro livello di indebitamento o alla loro eventuale domanda di dispositivi di impegno potrebbe aiutare a chiarire il ruolo effettivo del present bias.
Studi più recenti, come quello di Ru e Schoar, suggeriscono inoltre che le compagnie di carte di credito potrebbero deliberatamente proporre offerte più complesse, con costi nascosti e condizioni poco trasparenti, concentrandosi su aree geografiche con livelli di istruzione mediamente più bassi.
Questo comportamento indicherebbe una possibile strategia di sfruttamento della minore sofisticazione o della maggiore ingenuità di alcuni segmenti di consumatori.
Lavoro a cottimo e difficoltà di autocontrollo
Il present bias può influenzare anche scelte quotidiane come il numero di ore lavorate, in particolare quando il compenso è calcolato su base giornaliera o a cottimo.
In presenza di un forte present bias (magari combinato con vincoli di liquidità), un lavoratore potrebbe essere portato a lavorare di più nei giorni di paga – un fenomeno noto come payday effect – perché la ricompensa, immediatamente disponibile, pesa più dello sforzo richiesto.
Al contrario, nei giorni precedenti alla paga, il beneficio del lavoro extra (che si concretizzerà solo in futuro) viene scontato maggiormente, rendendo lo sforzo meno attraente.
Uno studio di Kaur et al. ha esplorato questo meccanismo analizzando il comportamento di lavoratori impiegati in attività di data entry in India.
Ai partecipanti è stata offerta la possibilità di scegliere un cosiddetto “contratto dominato”: invece di ricevere la paga standard w per ogni unità di lavoro svolta, potevano optare per una paga ridotta a w/2 fino al raggiungimento di un obiettivo giornaliero T auto-imposto.
Solo dopo aver raggiunto questo obiettivo, avrebbero ricevuto la paga piena w retroattivamente su tutte le unità prodotte.
Per un lavoratore senza problemi di autocontrollo, questo tipo di contratto sarebbe svantaggioso, poiché comporta il rischio di guadagnare meno nel caso in cui l’obiettivo non venga raggiunto.
Nonostante ciò, circa il 36% dei lavoratori ha scelto questo contratto almeno una volta, interpretando tale scelta come una strategia per incentivarsi a non interrompere il lavoro troppo presto e a mantenere la produttività.
Lo studio ha inoltre osservato che i lavoratori con un payday effect più marcato – cioè coloro che tendevano a lavorare di più nei giorni di paga – erano anche quelli più propensi a scegliere il "contratto di impegno".
Tutto ciò ha permesso di collegare direttamente il present bias (evidenziato dal comportamento nei giorni di paga) alla domanda di dispositivi di impegno.
L’introduzione di questi contratti ha portato a un aumento medio della produttività del 2,3%, un risultato equivalente, in termini di efficacia, a un incremento salariale del 18%.
Lo studio ha dimostrato il potenziale impatto dei dispositivi di impegno come strumento per migliorare le prestazioni lavorative.
Present bias e adozione di tecnologie benefiche a lungo termine
Il present bias può avere effetti importanti anche sull’adozione di tecnologie o investimenti che richiedono un costo immediato ma producono benefici solo nel lungo periodo.
Un esempio pratico è quello dell’acquisto di fertilizzanti agricoli: l’esborso avviene subito, mentre i benefici si realizzano solo al momento del raccolto, diversi mesi dopo.
Questa dinamica può portare gli agricoltori a sottovalutare i guadagni futuri o a destinare la liquidità disponibile ad altre spese più immediate, finendo per utilizzare meno del dovuto il fertilizzante anche quando il suo rendimento atteso è molto alto (in alcuni casi stimato oltre il 50% nel giro di pochi mesi).
Uno studio di Duflo et al. ha analizzato questo fenomeno tra gli agricoltori del Kenya occidentale.
Subito dopo il raccolto, quando dispongono di liquidità, molti agricoltori dichiarano l’intenzione di acquistare fertilizzante per la stagione successiva.
Tuttavia, al momento della semina, queste intenzioni spesso non si traducono in azioni concrete, a causa di spese impreviste o altre priorità che nel frattempo hanno assorbito le risorse disponibili.
Partendo da questa osservazione, è stata sperimentata una politica che prevede piccole riduzioni di prezzo o la semplice offerta della consegna gratuita del fertilizzante, a patto di effettuare l’acquisto subito dopo il raccolto, quando la disponibilità di liquidità è maggiore.
La consegna del fertilizzante, però, avveniva solo successivamente, al momento della semina. Questo meccanismo funziona di fatto come un dispositivo di impegno, perché consente di “bloccare” la decisione di investimento in un momento di maggiore "lucidità finanziaria", riducendo la possibilità di cedere a tentazioni di spesa nel periodo intermedio.
I risultati di queste politiche si sono dimostrati efficaci: hanno aumentato l’adozione del fertilizzante in misura maggiore della crescita generata da sconti anche più generosi (fino al 50%) offerti però solo al momento della semina, quando molti agricoltori non dispongono più dei fondi necessari.
I risultati ottenuti suggeriscono che il present bias, soprattutto quando interagisce con i cicli di liquidità tipici delle attività agricole, gioca un ruolo chiave nel determinare la mancata adozione di tecnologie potenzialmente molto vantaggiose.
4. Punti di forza e critiche
Il modello quasi-iperbolico e la ricerca sulle sue applicazioni offrono diversi elementi di valore che ne giustificano l’ampio utilizzo nell’analisi dei comportamenti intertemporali.
Innanzitutto, questo approccio fornisce un quadro teorico solido per spiegare la diffusa incoerenza dinamica nelle scelte delle persone, un fenomeno che il modello esponenziale standard non riesce a cogliere in modo adeguato.
Inoltre, consente di interpretare la domanda di dispositivi di impegno, un comportamento che resta invece inspiegabile all’interno della teoria della razionalità classica.
Un altro punto di forza rilevante riguarda la capacità di questo modello di offrire spunti utili per comprendere e, potenzialmente, mitigare comportamenti come la procrastinazione, l’eccessivo indebitamento con carte di credito, il basso livello di risparmio, le dipendenze (come il fumo o il consumo di alcol) e la mancata adozione di investimenti a lungo termine in ambiti di fondamentale importanza come la salute e l’istruzione.
Il modello quasi-iperbolico, inoltre, suggerisce possibili approcci più vicini alla realtà del comportamento umano, tra cui l’introduzione di scadenze intermedie, contratti di impegno, incentivi tempestivi di piccola entità oppure interventi che rafforzano la percezione del futuro.
Tutte queste soluzioni si basano sul riconoscimento di deviazioni dalle ipotesi di perfetta razionalità, tenendo conto delle fragilità e delle difficoltà di autocontrollo che caratterizzano molte decisioni individuali.
Accanto a questi punti di forza, l’applicazione empirica del modello quasi-iperbolico presenta però alcuni problemi che meritano attenzione.
Una delle difficoltà principali riguarda la distinzione tra individui pienamente sofisticati, ingenui oppure parzialmente consapevoli del proprio present bias: è probabile che la maggior parte delle persone si distribuisca gradualmente tra questi estremi, rendendo le previsioni comportamentali meno immediate e più complesse da formulare.
Inoltre, comportamenti apparentemente riconducibili al present bias – come la procrastinazione o l’eccessivo indebitamento – potrebbero essere spiegati, almeno in parte, da altri fattori: disattenzione, incertezza sul futuro, percezione distorta dei costi o dei benefici futuri (nota come planning fallacy), vincoli di liquidità o limitata alfabetizzazione finanziaria.
Questo intreccio di possibili cause rende spesso difficile isolare l’effetto specifico del present bias nelle analisi empiriche.
Un ulteriore problema riguarda gli aspetti metodologici di molti studi esistenti. In particolare, numerose ricerche, soprattutto quelle pionieristiche condotte in laboratorio o su campioni limitati (ad esempio, studenti universitari), si basano su dimensioni campionarie ridotte o su disegni sperimentali con poche unità di randomizzazione, come classi o villaggi.
La presenza di simili limitazioni solleva interrogativi sulla potenza statistica, sulla replicabilità e sulla robustezza dei risultati ottenuti.
A tutto questo si aggiunge il fatto che, nella pratica, la domanda di dispositivi di impegno sembra essere spesso inferiore a quanto previsto dai modelli teorici.
Le cause di questa discrepanza non sono facilmente identificabili, ma possiamo ipotizzare il concorso di diversi fattori: una certa ingenuità da parte degli individui, l'insicurezza riguardo al proprio futuro e l'inefficacia nella progettazione e comunicazione dei prodotti disponibili sul mercato.
5. Conclusioni
L’analisi delle preferenze temporali, e in particolare l’utilizzo del modello quasi-iperbolico e del concetto di present bias, ha arricchito la nostra comprensione del comportamento umano nelle scelte intertemporali.
Le applicazioni discusse mostrano come le deviazioni dal modello razionale standard abbiano effetti concreti sia nella vita quotidiana delle persone, sia nel funzionamento dei mercati.
Nonostante le difficoltà metodologiche nel misurare con precisione l’impatto del present bias e nell'isolarlo da altri fattori, la ricerca in questo campo continua a fornire chiavi interpretative essenziali per spiegare molte delle scelte che appaiono, a prima vista, irrazionali.
Comprendere questi meccanismi permette non solo di spiegare il comportamento umano, ma anche di progettare interventi più efficaci per favorire scelte coerenti con gli obiettivi di lungo periodo.
LEZIONI DI FINANZA COMPORTAMENTALE
1. Che cos'è la finanza comportamentale: quando psicologia e finanza convergono
4. Perché le buone intenzioni non bastano: le preferenze temporali e il bias del presente
5. Perché procrastiniamo? Bias del presente, scelte quotidiane e possibili soluzioni