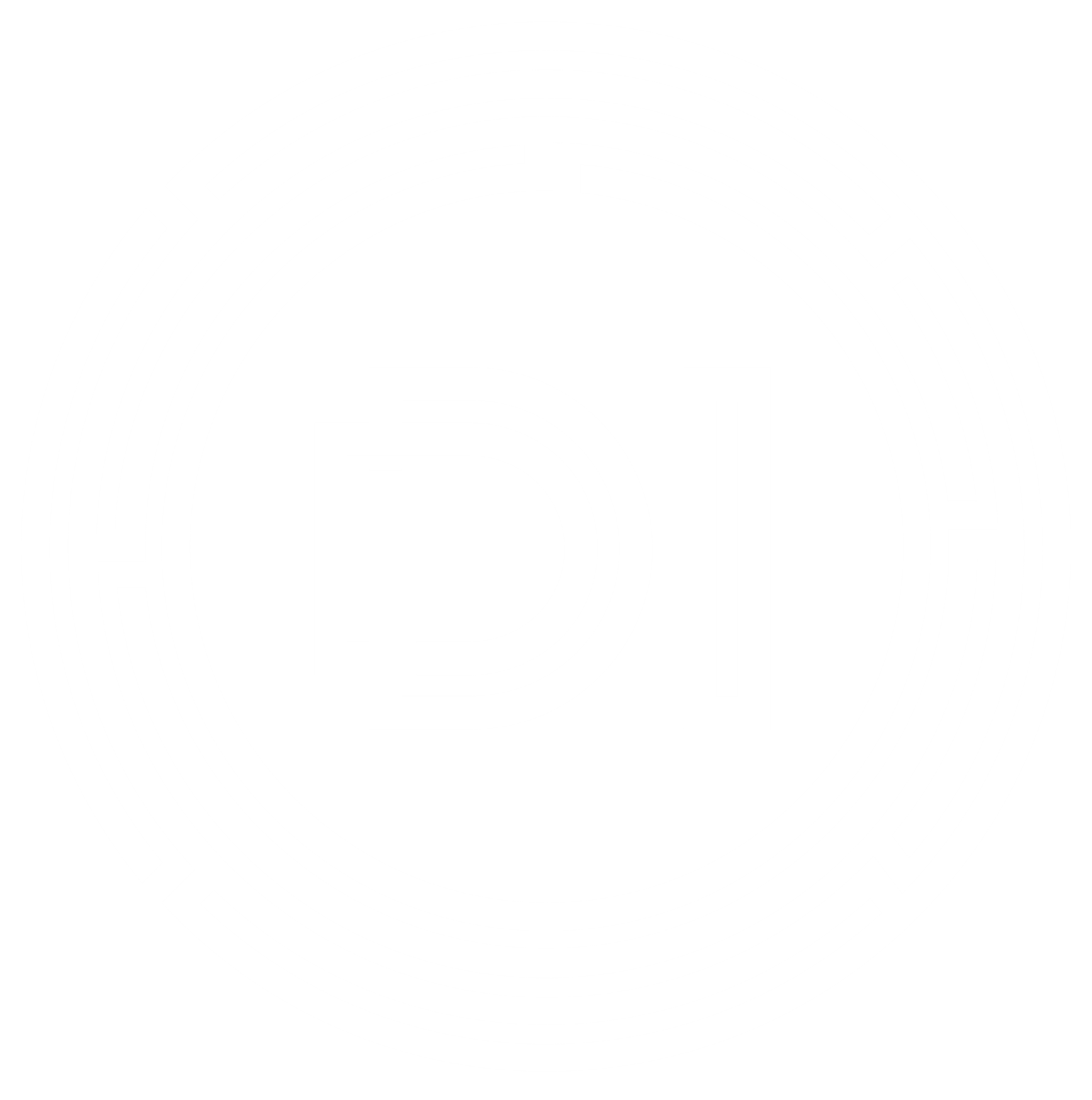4. Perché le buone intenzioni non bastano: le preferenze temporali e il bias del presente
- Information
- Finanza comportamentale 70 hits
- Prima pubblicazione: 07 Aprile 2025
«Mantenere i propositi fatti richiede più impegno che concepire onesti propositi».
Seneca
Perché, nonostante le migliori intenzioni, fatichiamo spesso a portare a termine i nostri piani a lungo termine?
Che si tratti di iniziare una dieta, smettere di fumare, risparmiare per il futuro o semplicemente rispettare una scadenza, molti di noi si trovano a fare i conti con una forma di auto-sabotaggio: una forza interna che ci spinge verso la gratificazione immediata, anche a costo di sacrificare obiettivi più importanti nel lungo periodo.
Questa distanza tra ciò che sappiamo essere la scelta giusta e ciò che effettivamente facciamo è un aspetto molto affascinante — e frustrante — del comportamento umano.
In questo articolo, esploreremo come la finanza comportamentale abbia cercato di risolvere questo enigma, andando oltre i modelli tradizionali di scelta razionale.
Cominceremo analizzando i limiti del classico modello di sconto esponenziale, il quale presuppone una coerenza nelle preferenze temporali che raramente riscontriamo nella vita reale.
Metteremo quindi in evidenza un concetto chiave: il “bias del presente”, ovvero la nostra tendenza a dare un peso eccessivo al momento attuale rispetto al futuro. Questo meccanismo psicologico è alla base della procrastinazione e di molte decisioni impulsive.
Successivamente, approfondiremo un modello più realistico e sofisticato: lo sconto quasi-iperbolico (noto anche come modello β-δ), già introdotto nell’articolo precedente.
Scopriremo come questo approccio riesca a descrivere in modo più preciso l’impazienza che proviamo nel presente e come le nostre decisioni possano variare drasticamente a seconda del tipo di persona che siamo: ingenui, inconsapevoli della nostra futura incoerenza, o sofisticati, consapevoli delle nostre debolezze e capaci di anticiparle.
Concluderemo accennando alle importanti implicazioni pratiche di queste scoperte, sia per le politiche pubbliche sia per le nostre scelte quotidiane.
Indice
- L’incoerenza temporale: perché i nostri piani spesso falliscono miseramente
- Modellare l’impazienza: Il modello β-δ e il ruolo della consapevolezza
- Prove empiriche e implicazioni pratiche
1. L’incoerenza temporale: perché i nostri piani spesso falliscono miseramente
Alla base del modello esponenziale vi è l’assunto di coerenza dinamica: le preferenze di un individuo rispetto a decisioni future dovrebbero restare stabili nel tempo, a parità di condizioni.
Immaginiamo una scelta semplice: preferireste ricevere 100 euro oggi oppure 105 euro domani?
Molti opterebbero per i 100 euro subito.
Secondo il modello esponenziale, se questa stessa scelta viene posticipata nel tempo — ad esempio, 100 euro tra 30 giorni oppure 105 euro tra 31 giorni — la preferenza dovrebbe rimanere invariata: se oggi preferisco 100 subito a 105 domani, dovrei anche preferire 100 tra 30 giorni a 105 tra 31 giorni.
Questa formulazione si basa su un tasso di sconto costante (δ), che applica la stessa “penalizzazione temporale” per ogni giorno di attesa, assicurando così una valutazione coerente nel tempo.
Nella realtà, però, i comportamenti osservati si discostano spesso da questa logica rigorosa: molte persone, pur scegliendo 100 euro oggi, sarebbero disposte ad aspettare un giorno in più in futuro per ottenere 105 euro, preferendo quindi 105 tra 31 giorni anziché 100 tra 30 giorni.
Quando la ricompensa è lontana nel tempo, l’attesa aggiuntiva sembra meno gravosa.
Un esempio emblematico di questa incoerenza è il cosiddetto bias del presente (present bias): la tendenza a dare un peso eccessivo alle ricompense immediate rispetto a quelle future.
Questo fenomeno aiuta a spiegare perché spesso pianifichiamo comportamenti virtuosi — come fare esercizio fisico regolarmente o risparmiare per la pensione — ma poi non li mettiamo in pratica quando arriva il momento di agire.
Il piccolo piacere immediato (come dormire mezz’ora in più) prevale sul beneficio a lungo termine (un corpo in forma grazie all’allenamento costante).
L’instabilità delle preferenze nel tempo mette dunque in discussione la validità del modello esponenziale, che non prevede un cambiamento del nostro grado di impazienza man mano che ci avviciniamo alla ricompensa.
2. Modellare l’impazienza: Il modello β-δ e il ruolo della consapevolezza

«Quante gioie possibili si sacrificano così all'impazienza di un piacere immediato».
Marcel Proust
Per descrivere in modo più realistico come le persone valutano le opzioni tra scelte distribuite nel tempo, è stato sviluppato il modello di sconto quasi-iperbolico, noto anche come modello β-δ (beta-delta).
Il modello β-δ introduce un parametro aggiuntivo – β (beta) – che cattura un aspetto fondamentale del comportamento umano: la forte discontinuità nella valutazione del tempo tra il “subito” (cioè il presente) e il “dopo” (qualsiasi momento futuro).
In altre parole, il modello riconosce che le persone non scontano il tempo in modo uniforme: tendono ad attribuire un valore decisamente maggiore alle ricompense immediate rispetto a quelle future, anche quando il ritardo è minimo.
È come se esistesse un vero e proprio “muro psicologico” tra l’oggi e il domani, che ci rende particolarmente impazienti nel momento presente.
Nel modello quasi-iperbolico, la funzione di sconto – che rappresenta il valore percepito oggi di una ricompensa futura – è definita così:
- 1, se la ricompensa è immediata (t = 0).
- βδt, se la ricompensa è futura (t > 0)
Dove:
- δ (delta), come nel modello esponenziale, rappresenta il tasso di sconto “standard” tra periodi futuri. Si assume di solito che δ sia vicino a 1 (ad esempio, 0,90-0,99), indicando una certa pazienza per ricompense ritardate nel tempo.
- β (beta), compreso tra 0 e 1, rappresenta l’intensità del bias del presente. Più β è vicino a zero, maggiore è la preferenza per la gratificazione immediata. Quando β = 1, il modello si riduce al caso esponenziale, e il bias del presente scompare.
Questa formulazione consente di rappresentare in modo elegante il forte deprezzamento delle ricompense future rispetto a quelle immediate, pur mantenendo coerenza temporale tra periodi futuri (grazie al parametro δ).
Vediamo un esempio numerico. Supponiamo che β = 0,5 (bias del presente forte) e, per semplicità, δ = 1 (assenza dello sconto esponenziale standard).
- Scelta 1: 100 euro oggi vs 120 euro domani.
- Valore percepito dei 100 euro oggi = 1 × 100 = 100.
- Valore percepito dei 120 euro domani (t=1) = β × δ1 × 120 = 0,5 × 11 × 120 = 60.
- Decisione → Si preferiscono i 100 euro oggi (100 > 60).
- Scelta 2: 100 euro tra 30 giorni vs 120 euro tra 31 giorni.
- Valore percepito dei 100 euro tra 30 giorni (t=30) = β × δ30 × 100 = 0,5 × 130 × 100 = 50.
- Valore percepito dei 120 euro tra 31 giorni (t=31) = β × δ31 × 120 = 0,5 × 131 × 120 = 60.
- Decisione → Oggi, si preferiscono i 120 euro tra 31 giorni (60 > 50).
Questo esempio mostra come il modello β-δ catturi l’incoerenza temporale: la stessa scelta (100 vs 120 euro, con un giorno di differenza) viene valutata diversamente a seconda di quando deve essere presa la decisione. Il fattore β penalizza tutto ciò che non è immediato.
Un aspetto fondamentale del modello è il grado di consapevolezza che le persone hanno del proprio bias del presente. In questo contesto, si distinguono due profili opposti:
- Gli ingenui (naïf): credono erroneamente che le loro preferenze future saranno coerenti con quelle attuali. Pianificano azioni virtuose (“inizio la dieta domani”), ma quando il momento arriva, cedono alla tentazione del piacere immediato. Non si rendono conto che il loro “sé futuro” sarà altrettanto vulnerabile quanto il “sé attuale”, quando il momento futuro arriverà.
- I sofisticati: sono consapevoli della propria tendenza a procrastinare o cedere alle tentazioni. Per proteggersi, adottano commitment devices ("strumenti di impegno"), come addebiti automatici delle somme da investire, uso di app che limitano l’accesso ai social media, condivisione pubblica di obiettivi per creare pressione sociale su loro stessi. Questi strumenti aiutano a ridurre la libertà d’azione futura, limitando le possibilità di procrastinare e aumentando le probabilità di rispettare i propri piani.
Immaginiamo uno studente che deve completare un compito entro 3 giorni. Il “costo” percepito del lavoro da fare (in termini di fatica e stress) aumenta col passare del tempo:
- Giorno 1: Costo 3 (gestibile).
- Giorno 2: Costo 5.
- Giorno 3: Costo 8 (molto stressante).
Supponiamo, inoltre, che β=0,5 e δ=1.
Comportamento dell’ingenuo:
- Il giorno 0, viene effettuata la pianificazione. Lo studente valuta, oggi, i costi futuri scontati: al giorno 1, sono pari a 0,5 × 3 = 1,5; al giorno 2 a 0,5 × 5 = 2,5 e, al giorno 3, a 0,5 × 8 = 4. Lo studente pianifica, quindi, di svolgere il compito il giorno 1, dato che il costo percepito è minore.
- Il giorno 1, lo studente si trova di fronte alla decisione relativa allo studio: come tutti sappiamo, non è che se abbiamo pianificato una cosa ieri, allora oggi la svolgiamo automaticamente. Per decidere, lo studente confronta il costo immediato (3) con il costo percepito del giorno 2, che è pari a 0,5 × 5 = 2,5. Poiché 2,5 è minore di 3, lo studente rimanda lo svolgimento del compito al giorno 2. Che cosa sfugge all’ingenuo? Il suo errore è non considerare che il giorno 2 la sua valutazione cambierà di nuovo!
- Il giorno 2, lo studente si trova nuovamente di fronte alla decisione relativa allo studio: confronta il costo immediato (5) con il costo percepito del giorno 3, che è pari a 0,5 × 8 = 4. Poiché 4 è minore di 5, lo studente procrastina lo svolgimento del compito al giorno 3.
- Risultato → il compito viene svolto all’ultimo momento (giorno 3), subendo il costo massimo, nonostante la pianificazione iniziale avesse previsto tutt’altro.
Comportamento del Sofisticato:
- Il giorno 0, viene effettuata la pianificazione, che stavolta è “consapevole”. Lo studente valuta i costi futuri scontati ragionando a ritroso: se arriva al giorno 2, sa che rimanderà al giorno 3 (perché sa che il costo di 4 del giorno 3, calcolato come visto in precedenza il giorno 2, è minore di 5); se arriva al giorno 1, sa che farà il compito subito, ovvero il giorno stesso (perché sa che il costo di 3 del giorno 1 è minore di 8, il costo di quando finirà per fare il compito se dovesse rimandarlo al giorno 2 (che poi diventerà giorno 3).
- Decisione al giorno 0: lo studente sofisticato capisce, quindi, che le vere opzioni sono fare il compito il giorno 1 (costo percepito oggi: 0,5 × 3 = 1,5) o finire per farlo il giorno 3 (costo percepito oggi: 0,5 × 8 = 4), e sceglie di impegnarsi fin da subito a svolgere il compito il giorno 1.
- Risultato → Il sofisticato anticipa la propria tendenza a procrastinare e agisce per evitarla, sostenendo il minor costo possibile.
Un aspetto da sottolineare è che la distinzione tra individui ingenui e sofisticati non dipende direttamente dal livello di impazienza espresso dal parametro β.
Non è corretto pensare che l'ingenuo sia semplicemente colui che ha un β molto basso (e quindi un forte bias del presente) e il sofisticato colui che ha un β più alto (e quindi un bias più debole): entrambi i tipi di individui possono, in linea di principio, avere qualsiasi valore di β < 1.
La vera differenza risiede nella consapevolezza (o nella sua mancanza) riguardo alla propria futura incoerenza temporale e nella capacità di stimare correttamente come agirà il proprio “sé futuro”.
Un individuo ingenuo può avere un β basso o relativamente alto, ma il suo errore sta nel non prevedere – o nel sottostimare – che il suo “sé futuro” sarà anch'esso influenzato da quel β quando dovrà prendere una decisione: crede, erroneamente, nella propria futura coerenza o pensa che la sua forza di volontà sarà maggiore.
Al contrario, un individuo sofisticato è tale perché, indipendentemente dal suo specifico valore di β, è consapevole di questo bias e anticipa correttamente che esso influenzerà le sue scelte future.
È questa consapevolezza ciò che gli permette di seguire la strategia meno costosa, ad esempio scegliendo piani d’azione realistici fin da subito o utilizzando "strumenti di impegno" per contrastare la tentazione di non rispettare gli impegni.
Esistono anche situazioni intermedie, in cui le persone riconoscono parzialmente il proprio bias ma ne sottovalutano l’intensità o gli effetti.
Questa condizione, nota come partial naïveté, rende la dinamica delle decisioni intertemporali ancora più complessa e sfumata.
3. Prove empiriche e implicazioni pratiche
Uno degli studi più noti e influenti in questo ambito è quello di Ariely e Wertenbroch, che ha analizzato come le persone — in particolare gli studenti — utilizzino meccanismi di autocontrollo, come scadenze autoimposte, per gestire la procrastinazione nella vita reale.
I risultati hanno mostrato che gli studenti che si imponevano scadenze anticipate e vincolanti tendevano a ottenere risultati migliori rispetto a chi rimandava tutto all’ultimo momento.
Il motivo è legato al fatto che le scadenze anticipate fungono da "strumenti di impegno" (commitment devices), aiutando a contrastare il bias del presente.
Le implicazioni pratiche sono notevoli: comprendere il ruolo del bias del presente può guidare la progettazione di politiche pubbliche più efficaci, spesso basate su principi di nudging (spinte gentili verso comportamenti desiderabili).
L’esempio emblematico è l’iscrizione automatica (opt-out) ai fondi pensione, che sfrutta l’inerzia comportamentale per incentivare il risparmio a lungo termine. Il modello opt-in (iscrizione su richiesta), invece, comporta tassi di adesione molto più bassi, proprio a causa della tendenza alla procrastinazione.
Meccanismi simili sono alla base di strumenti come:
- Tassazione di prodotti dannosi (es. sigarette, bevande zuccherate), per scoraggiare consumi impulsivi.
- Periodi di “recesso” per contratti vincolanti, che danno tempo per riflettere e limitano decisioni dettate dall’impulso.
Le neuroscienze offrono un ulteriore sostegno empirico ai modelli comportamentali.
Studi di neuroeconomia, che uniscono economia, psicologia e neuroscienze, hanno dimostrato che:
- La valutazione di ricompense immediate attiva principalmente aree del sistema limbico, associate alle emozioni e alla gratificazione istantanea.
- La valutazione di ricompense future, invece, coinvolge la corteccia prefrontale, responsabile della pianificazione e del controllo.
Queste evidenze suggeriscono che il bias del presente non è solo psicologico, ma ha una base neurologica osservabile, radicata nei meccanismi cerebrali che regolano le nostre scelte.
Il passaggio dal modello esponenziale a quello quasi-iperbolico rappresenta un importante avanzamento nella comprensione delle decisioni temporali.
Accettare che le preferenze possano cambiare sistematicamente — e che gli individui siano talvolta dinamicamente incoerenti — non significa considerare le persone deboli o irrazionali: al contrario, è un passo verso una rappresentazione più realistica e utile del processo decisionale umano.
Comprendere questi meccanismi è punto di partenza per imparare a gestirli, sia a livello individuale, adottando strategie di autocontrollo, sia a livello collettivo, attraverso politiche pubbliche progettate per tenere conto dei limiti cognitivi delle persone.
LEZIONI DI FINANZA COMPORTAMENTALE
1. Che cos'è la finanza comportamentale: quando psicologia e finanza convergono
4. Perché le buone intenzioni non bastano: le preferenze temporali e il bias del presente